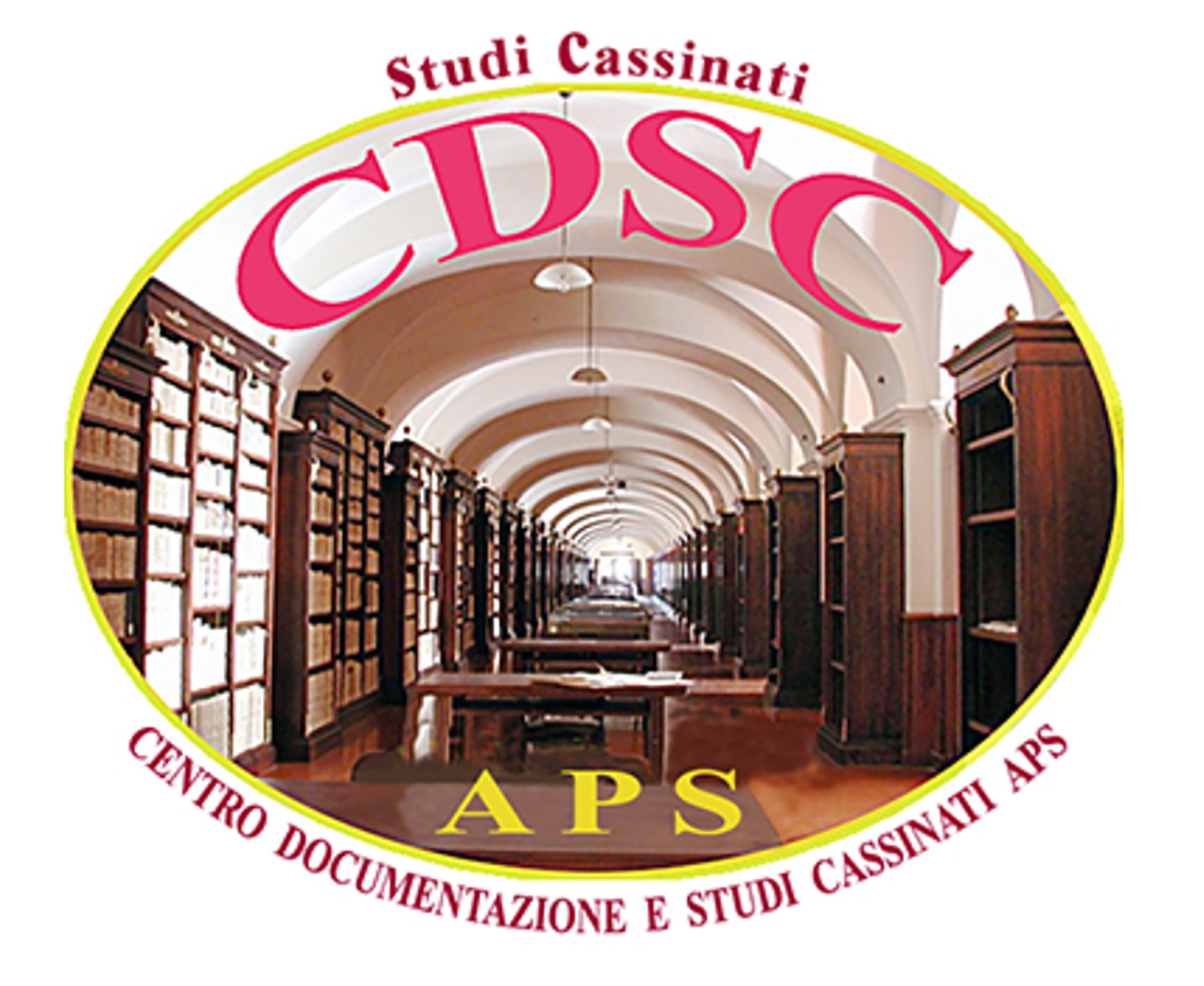.
«Studi Cassinati», anno 2021, n. 1-2
> Scarica l’intero numero di «Studi Cassinati» in pdf
> Scarica l’articolo in pdf
di Luigi Tosti*
Raccontando in questo libro come miseramente rovinasse la famosa Badia di Montecassino per fortissimo terremoto, mi veniva a taglio purgare que’ poveri monaci che camparono da quella rovina, da vergognoso peccato di che furono accagionati per la mala interpretazione di un frizzo di Dante, e per certo malefico talento di certi uomini corrivi a credere, a pubblicare, ed anche a creare cose che tornano a vituperio de’ monaci e dei chierici. Dirò della cagione che condusse alcuni ad incolpare i monaci di vandalico governo fatto dei libri; degli argomenti che sembravano affermare la vituperosa congettura, e finalmente, non come monaco, ma come uomo che ha un pocolino di ragione, combatterò la torta sentenza, che ancora disonesta la memoria di que’ vecchi Cassinesi. Giudichi chi mi legge.
Nel canto XXII del Paradiso Dante vede molti illustri spiriti come
… cento sperule, che insieme
Più s’abbelivan con mutui rai,
e come margherite, la maggiore e la più loculenta delle quali era san Benedetto, che gli si fece innanzi; ed udì il poeta queste parole:
Quel monte a cui Cassino è nella costa
Fu frequentato già in sulla cima
dalla gente ingannata e mal disposta
…….
Ma per salirla mo nissun diparte
Da terra i piedi; e la regola mia
Rimasa è giù per danno delle carte.
Le mura che soleano esser Badia
Fatte sono spelonche, e le cocolle
Sacca son piene di farina ria.
Tutti coloro che han letto e leggeranno Dante trovano in questi versi una brutta dipintura de’ monaci, come in quelli che seguono, dei chierici, perché eransi dilungati dall’austera ragione del loro vivere. Solo quelle parole
… e la regola mia
Rimasa è giù per danno delle carte.
travagliavano le menti dei Comentatori, generazione di uomini che imparenta con quella dei cercatori del lapis philosophorum. Un antico Comentatore spiega così: la regola sta pure in scrittura, ma non in opera. Il Landino: è rimasta qui in danno delle carte. Il Vellutello: perché esse (le carte) nello scrivere essa sua regola si consumano senza far utile ai monaci, che non l’osservano. Il Venturi: atteso il consumo che si fa di quelle (delle carte) senza alcun pro, non trovandosi chi la osserva (la regola), ed in pratica la riduchi. Il Lombardi: per consumare inutilmente carta a trascriverla. Il Poggiali: questa regola … è a dir vero, da loro conservata, e custodita trascritta; anzi se ne fanno continuamente molte copie, ma queste non servono, che ad un inutile consumo di carta. Il Biagioli: cioè della carta che si consuma in copiarla e ricopiarla, poiché nessuno pon mano ad essa. Il P. Cesari: la mia regola non porta che la spesa delle carte, ove è scritta: la quale spesa è gittata al diacine.
Chiosa ben differente dalle anzidette produsse Benvenuto da Imola, i comenti del quale su Dante furono pubblicati dal Muratori fin dall’anno 1738, che erano conosciuti dagli anzidetti comentatori. Secondo l’imolese il danno delle carte non fu altro se non un certo barbaro costume dei monaci di Montecassino di guastare i libri, tagliando il margine delle scritte membrane, di che si componevano i codici, per formarne piccioli salteri che vendevano alle donne, e certi libercoli, che anche vendevano ai fanciulli. Ecco il danno delle carte secondo Benvenuto. In questa sentenza egli era condotto da certo racconto che gli avrebbe fatto M. Boccaccio sulle pessime condizioni in che trovò la libreria Cassinese. Narra il Boccaccio “come, essendo in Puglia, cioè nel reame napolitano, traesse al nobile monastero Cassinese, e bramoso di vedere la libreria, la quale aveva inteso dire, essere nobilissima, si fece a chiedere con modi dimessi, ad un monaco, che per grazia gliela volesse aprire. Ma questi con brutto piglio risposegli – Fatti in sù: la è aperta. E questi andatovi la trovò senza porta e senza chiavi, un erbajo su per le finestre, e panche e libri seppelliti nella polvere; e tutto meraviglia recatosi in mano or questo or quel libro, trovonne alcuni scemi di quaderni strapparti, e del margine delle pagine, ed in mille maniere guasti. Andandogli al cuore che le fatiche e gli studi di chiarissimi ingegni fossero cadute in mani di scellerati uomini, dolorando e piagnendo se ne andò. E fattosi innanzi ad un monaco, ed interrogato del disonesto governo fatto di quei preziosissimi libri, costui rispose: che alcuni monaci volendo trar guadagno di due o cinque soldi, secavano un quaderno e ne facevano uffizioli che vendevano ai fanciulli; e dei margini ne facevano (brevia) che anche vendevano alle femmine. E chiuse poi Messer Boccaccio il lagrimevole racconto con queste parole: Or va uomo studioso a dar la testa al muro, per comperare libri”.
La chiosa dell’Imolese confermato dal fatto così chiaro, fu un vero gioiello (che per altro tutti i comentatori di Dante non vollero raccogliere), il quale fu da qualcuno tolto dal fango, e posto in piena luce del sole, non per innocente sollazzo di dare del somaro a que’ poveri monaci; ma per amore di verità, e di conoscere alla fine qual diavolo si annidasse in quelle parole dello Alighieri: per danno delle carte. Ora se ad altri fu lecito un sì avventuroso scoprimento, non sarà sconvenevole a me produrre una mia sentenza, la quale i leggitori potranno mettere a confronto con quelle di tutti comentatori, e quella di Benvenuto e poi giudicare e scegliere.
Tutte le interpretazioni anzidette possono restringersi a questa doppia sentenza: 1° Il danno delle carte essere un consumo inutile che i monaci facevano nel trascrivere la regola che non osservavano. 2° Il danno delle carte (secondo l’Imolese) essere il tagliare e sconciare dei codici che facevano i monaci di Montecassino. La prima sentenza a me non va a sangue. Che danno è mai questo che patiscono le carte, perché se ne fa uso grandissimo per iscrivere di continuo la regola di san Benedetto che non si osserva? Quale relazione tra la caduta della regola ed il consumo delle carte? E l’uso ed il danno non sono sinonimi, né l’usare di una cosa è lo stesso che mandarla a perdizione.
Il danno, secondo Benvenuto, è il guasto de’ libri fatto dai monaci di Montecassino. E questa sentenza neppure mi va a sangue, né anderà più a quanti altri han fior di senno. E qui, fatta riverenza a tutti gli osservandissimi comemtatori di Dante, preteriti presenti e futuri, umilmente dirò. È canone di vera logica che di una scrittura, l’autore di cui non può parlare, perché è morto, il primo senso da abbracciarsi sia il letterale; se poi questo renda contradizione tra gli antecedenti e i conseguenti, se rechi qualche assurdo, ecc., allora si può correre ai traslati, alle ironie, ai frizzi, ecc. Ora, ravvolgendo nell’animo quel maledetto danno delle carte, vedi chiaro il senso, senza corre al consumo della carta, o al taglio e squinternar dei codici. Dice san Benedetto – la regola mia rimasa è giù per danno delle carte. – Qui si può intendere o che il danno delle carte fece rimanere giù la regola, o che la regola rimasta giù dannificò alle carte. Il primo senso non è punto ragionevole, perché qual danno di carte poteva mandar giù la regola di san Benedetto? piuttosto il secondo parmi ragionevole e vero, cioè, che la regola rimasa giù dannnificò alle carte. Ed ecco allora come va dolce la spiegazione: I monaci han messo d’un canto la regola, ossia non sono più buoni monaci, per danno, o a danno, o in danno delle carte, cioè delle lettere e degli studii. Dante, che ben conosceva l’operato dai monaci per conservare le lettere nel tempo della barbarie (essendo buoni monaci), non può tenersi dal lamentare il danno che veniva alle lettere (essendo essi tristi). Non ti pare, o mio lettore, che questo sia il senso di quelle parole, e non sia mestieri correre al copiare e ricopiar della regola con danno delle carte, perché si consumano, o ai furfanti tagli dei codici fatti dai Cassinesi? Ciò io dico con tutta soggezione a quanti altri potran dire di meglio, perché mi riconosco ignorante monaconzo successore di que’ tristi guastatori di codici, che fecero pianger messer Boccaccio.
E a rincalzo del detto giova osservare che Dante, quando poneva in bocca a san Benedetto i noti versi del 22° canto, non pensava a Montecassino, e molto meno, a quel che facessero i monaci. Dal verso 37° a tutto il 51° non parla del monastero di Montecassino, ma degli antichissimi visitatori del monte che adoravano Apollo, e che furon da san Benedetto convertiti a Cristo; poi di tutt’i santi monaci che furono fuochi contemplanti, e che dentro i chiostri Fermar li piedi e tennero il cuor saldo. Dal verso 52° fino a tutto il 72° è descritto il dialogo tra Dante e san Benedetto, e non si parla di monaci. Dal 73° in poi rompe quel torrente di contumelie contro i monaci, e neppure trovo alcuna sillaba che accenni in particolare a Montecassino, bensì un’amarissima diceria (messa in bocca a san Benedetto) di Dante. Or tutte quelle cortesissime frustate di Badie tramutate in spelonche di ladri, e di que’ monaci vestiti di cocolle, mutati in sacca piena di farina ria, non vengono che dalla prima sentenza: la regola mia rimasa è giù per danno delle carte, ossia dalla inosservanza della regola. E, se questa inosservanza derivava dal tagliare dei codici che facevano i Cassinesi, solo i Cassinesi potevano accagionarsi di abbandono di detta regola. Ma il discorso è volto in generale a tutto l’ordine: dunque o bisogna dire che il taglio dei codici era colpa di tutto l’ordine, o è mestieri dire che Dante dalla colpa di una sola Badia derivi quella di tutte le altre; ed allora Dante avrebbe fatto peccare di solenne ingiustizia quella margherita, che era la più luculenta fra tutte.
Vengo ora al grazioso racconto di Boccaccio, e farò in modo, che chi mi legge potrà da sé medesimo conoscere, se vero o falso sia tutto il racconto, o pure allargato e guernito di un falso accompagno di circostanze del famoso novelliere.
Il Boccaccio, come sembra, due volte trasse in Napoli. La prima volta vi andò nell’anno ventottesimo di sua vita, cioè nel 1341, quando s’invaghì di Fiammetta, cui intitolò in quest’anno la sua Teseide. La seconda volta vi si condusse, invitato dal gran Siniscalco del regno di Napoli, Niccolò degli Acciajoli; la qual andata crede Sebastiano Ciampi essere avvenuta nel 1348, e vi dimorò per ben tre anni1. O dunque il Boccaccio visitò Montecassino nella prima, o nella seconda dimora fatta in Napoli, perché egli diceva a Benvenuto: dum essem in Apulia. Nell’incertezza del tempo in cui il Boccaccio visitasse la Badia, possiamo conghietturare, che questa avvenisse nella seconda dimora che fece in Napoli, e perché questa fu più lunga della prima, e perciò gli dava più agio a recarsi a Montecassino; e perché più maturo di anni, e forse meno legato degli amori di Fiammetta, che gli si appigliarono nell’anno 1341, poteva volgere il pensiero alle Badie e alle librerie. Se dunque venne a Montecassino tra il 1348 e 1351, trovò la Badia in assai misero stato. Il terremoto del 1349 avevala abbattuta, e poiché eran vescovi e non abate, e perciò nessun riparatori di quei danni, i monaci si aggiravano tra que’ rottami, non come uomini che pensino a’ libri ed a scienze, ma come infelici che lamentavano la patita sciagura, ed il nessuno argomento che loro si offeriva a far risorgere la famosa loro sede. Fino al tempo del pontificato di Urbano V i monaci vissero sotto le capanne per difetto di tetto che li coprisse. Oltre al terremoto avevano sofferte certe visite divote degli Ungheri di Ludovico e del procelloso Jacopo di Pignataro, i quali non solo avevano dato di piglio ai calici ed alle croci di argento, ma anche ai libri che rubarono. Nè ora vo conghietturando, perché nelle lettere di papa Urbano V da me citate ed anche tradotte in volgare nelle narrazioni di questo libro è detto chiarissimo che dessero di mano ai libri. “Monasteria, hospitalia, et alia pia loca saecularia et regularia, a dicto monasterio dependentia invadere, frangere, capere, occupare, occupata diruere et incendio concremare; ac ecclesias et monasteria, et loca ipsa libris calicibus … spoliare”. Se soffrissero i libri qualche danno in questi replicati saccomanni, ognuno può immaginare. Adunque dell’erba cresciuta sulle finestre, della polvere e del guasto dei libri non dubito, guardando come e quanto fossero stati tempestati que’ poveri monaci per terremoti, per invasione di Ungheri e di ribellati vassalli. Dubito forte poi di quel ritagliare di margini e strappar di quaderni per formarne uffiziuoli, e venderli alle femminucce. E basterà un solo argomento di fatto presente a raffermarmi nel dubbio, anzi a non aggiunger fede alle narrate abrasioni. I codici che furono veduti dal Boccaccio, e che gli trassero le lacrime dagli occhi, sono quelli stessi che ora si vengono nell’archivio Cassinese, perché scritti nel 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° secolo: e su di ciò non cade dubbio. Or questi codici, sebbene alcuni ci si offrono guasti nel principio e nella fine (ed in quale archivio non si trovano questi danni?) come parti più esposte al mal governo dei predatori, tuttalvolta nissuno trovasi avere i margini tagliati, o strappati in quaderni. I codici in foglio più degli altri lussureggianti di margine, avrebbero dovuto più degli altri patire questi tagli, eppure questi sono i meglio conservati. Se poi questi vandalici risecamenti si facevano per lucrare i due o i cinque soldi, i monaci avrebbero messe le mani a tagliare quelle bellissime lettere capitali dipinti, e venderle, dovendo queste più apprezzarsi, almeno pel colore, dalle donnicciuole e dai bambini. E queste lettere sono ancora al posto loro belle e vive. Questi sono argomenti di fatto, e, per abbatterli, sarebbe mestieri trovarne altri contrarii, ma di simile natura. Adunque conchiudo come uomo che cerca la verità, e non di purgare con isforzate ipotesi i monaci di questa colpa: se venne Boccaccio in Montecassino fra il 1348 e 1351, non dubito che trovasse in pessimo stato la libreria per le pessime condizioni dei monaci, rubati, cacciati imprigionati dagli Ungheri, e dal terribile Jacopo di Pignataro, come è chiaro dai documenti originali del tempo, e disertissimi per furia di terremoti. Ma non è da aggiugnersi fede a quel taglio di margini e quaderni venduti da quei perditissimorum hominum, di monaci: ma piuttosto, se non vogliamo far divorzio con ragione, è a dire che tutte queste circostanze furono immaginate dall’autore del Decamerone per mordere e beffarsi dei monaci. Se poi sarà argomento di fatto da opporre agli anzidetti, io di buon grado dannerò le barbarie di quei monaci, che nella barbarie furono soli e teneri conservatori di ogni umano sapere.
.
* L. Tosti, Storia della Badia di Montecassino, Vol. III, Documenti e note, XII, L. Pasqualucci Editore, Roma 1889, pp. 307-313.
.
(70 Visualizzazioni)