.
«Studi Cassinati», anno 2019, n. 1
> Scarica l’intero numero di «Studi Cassinati» in pdf
> Scarica l’articolo in pdf
.
di Manlio Del Foco
Per ricordare pienamente Manlio Del Foco, scomparso il 24 marzo 2019 esattamente a 75 anni di distanza dal suo forzato, «doloroso» e «più tragico» sfollamento da Terelle a Colle San Magno, «Studi Cassinati», con il consenso della famiglia, ha inteso pubblicare il toccante ricordo di quei drammatici momenti già stampato nella sezione Testimonianze del volume di A. G. Ferraro, Cassino dalla distruzione della guerra alla rinascita della pace, Cdsc-Onlus, Cassino 2007, pp. 155-166, e poi riproposto nel 2013 in una edizione pro manoscritto fuori commercio, corredato di foto.
.
Provati già dalla perdita del nonno materno, morto sotto le macerie della sua villa durante il primo bombardamento di Cassino il 10 settembre del 1943, dopo essere stati in campagna, ci siamo trasferiti, sempre in cerca di sicurezza, prima a Caira presso la gentile signora Sara Morigine, le cui due belle nipotine, più o meno della nostra età, Mariolina e Sarina, furono nostre instancabili compagne di giochi, poi, incalzati dagli eventi, ci siamo spostati tutti nella villetta del dottore Caprio, più in alto a mezza costa.
Avevamo tutta la valle sotto di noi e perciò, i grandi con preoccupazione, noi ragazzi con interesse e divertimento, potevamo vedere i movimenti dei carri e delle truppe dei tedeschi, gli attacchi che essi subivano dagli aerei nemici e soprattutto dalle loro artiglierie delle quali sentivamo, contandoli, i colpi di partenza e ne controllavamo le esplosioni in arrivo.
Una mattina, ricordo, il sole era già alto e il cielo sereno, eravamo tutti abbastanza lontani da casa, quando squadriglie di fortezze volanti, ad ondate, iniziarono un bombardamento a tappeto su Cassino, sulla pianura, sulle pendici di Montecassino e su quelle di monte Cairo dove noi eravamo.
La contraerea tedesca sparava furiosamente da tutte le postazioni e le schegge dei proiettili che esplodevano in alto cadevano intorno a noi rifugiati sotto gli alberi. Dagli aerei colpiti si erano lanciati con il paracadute alcuni membri degli equipaggi e io mi chiedevo se sarebbero arrivati vivi a terra visto che scendevano lentamente tra tutte quelle esplosioni. Era stato per me uno spettacolo terribile e nello stesso tempo entusiasmante. Con il passare dei giorni la nostra sicurezza diveniva sempre più precaria e perciò ci siamo trasferiti verso la metà di novembre a Terelle, paesino incastonato in un versante di monte Cairo a 900 metri di altitudine, i cui abitanti erano dediti soprattutto alla pastorizia e ad una agricoltura di sussistenza.
Abitavamo in una casa di due stanze, una sull’altra, collegate tra loro da una scala di legno, dotata di una cisterna che raccoglieva l’acqua piovana di cui ci servivamo per bere e per le altre necessità. Il paese non aveva acquedotto. Eravamo otto in famiglia: mio padre Ottorino Del Foco, medico chirurgo, mia madre Bianca Maria Baccari, i miei fratelli Oreste di 11 anni, Erberto di 9, Edoardo di 2, io, Manlio di 10, zia Zaira e zio Edoardo, rispettivamente sorella e zio di mio padre, che non aveva voluto fino all’ultimo lasciare il suo studio a Cassino perché, anche medico delle ferrovie, non poteva abbandonare senza assistenza i ferrovieri, il cui lavoro era diventato estremamente pericoloso per i frequenti mitragliamenti a cui i treni erano sottoposti. Sia pure nelle ristrettezze, la vita scorreva abbastanza serenamente: noi ragazzi andavamo spesso nel bosco a fare legna, papà assisteva come poteva i malati, soprattutto i profughi di Cassino, tra i quali ricordo il professore Tommaso Piano, assiduo frequentatore della nostra casa e sempre più bisognoso di aiuto per sé e per la madre anziana e malata. (Saranno tutti e due fucilati la sera del rastrellamento perché il professore, non volendo abbandonare la madre, si era scagliato contro i tedeschi che volevano portarlo via).
Nella piana, intanto, la battaglia infuriava e da noi ne arrivavano sempre più minacciosi i rumori. I “grandi”, per darsi e per darci coraggio, affermavano che la guerra avrebbe solo sfiorato il comune montano di Terelle poiché la strada asfaltata non aveva sbocchi.
I soldati tedeschi, invece, fortificavano le loro linee e disseminavano la campagna di fili telefonici per mettere in comunicazione il comando con le postazioni avanzate e, di tanto in tanto, facevano irruzione nelle case per razziare quello che ritenevano facesse loro comodo.
La tragedia fu improvvisa. Era il 24 gennaio 1944. La giornata era limpida ma molto fredda, la neve era caduta abbondante nei giorni precedenti. Nel primo pomeriggio, noi piccoli avevamo avuto il permesso di allontanarci per andare verso un belvedere da cui potevano vedersi i movimenti delle truppe e il fuoco delle artiglierie nella valle sottostante. Avevamo percorso appena un centinaio di metri, quando con fischi laceranti cominciano a cadere intorno a noi le prime granate. Di corsa, quasi strisciando, siamo rientrati in casa per riunirci tutti in un angolo, al riparo dalle schegge che entravano dalla finestra e si conficcavano nel muro di fronte e nella scala di legno. Pensavamo di stare relativamente al sicuro e invece inaspettati e frenetici colpi sull’uscio di casa, accompagnati da invocazioni di aiuto, inducono mio padre ad aprire la porta. Era una donna, anche lei di Cassino, conosciuta da me solo di vista, che, scarmigliata, con gli occhi sbarrati, in preda ad una crisi isterica, incitandoci a fuggire si aggrappa alla mantella che mio padre indossava e come una furia lo trascina, seguito da Erberto e Oreste, fuori di casa proprio nel momento in cui una granata scoppiava vicino al nostro uscio. Al grido di Erberto che si era immediatamente accorto del ferimento di papà, ci siamo precipitati tutti fuori, incuranti delle esplosioni che ancora proseguivano intense. Papà era in piedi, solo con Erberto, sembrava sano. Senza parlare si avvia, vomitando sangue ad ogni passo, verso l’ingresso della casa adiacente alla nostra dove, una volta entrati, ci ha guardato disperato uno a uno e, accennando il segno della croce, è caduto morto. Solo allora ci siamo accorti che anche Oreste era stato ferito: giaceva in una pozza di sangue e senza un lamento vicino al padre. La donna che aveva bussato alla nostra porta e di cui non ricordo più il nome per averlo poi cancellato dalla mente, subito dopo la detonazione fatale, sana e salva era sparita.
Terminato finalmente il cannoneggiamento, mamma, riportato Oreste in casa, esce in cerca di aiuto e torna, dopo molto tempo, con tre conoscenti cassinati con i quali recupera in fretta il corpo di mio padre e lo adagia su un materasso nella nostra stanza a pianterreno. Un violento bombardamento aereo si abbatte poco dopo sul paese. La casa sobbalzava violentemente e le schegge devastavano il tetto coperto di neve; sembrava che tutto dovesse crollare da un momento all’altro. Calata la notte e ritornata la calma, nella camera soprastante lo zio Edoardo, ottantaduenne e ammalato, straziato per la perdita del nipote, chiedeva aiuto. Giaceva nel suo letto completamente bagnato d’acqua gelida che gocciolava attraverso gli squarci provocati dalle schegge. Mi è morto tra le braccia mentre cercavo di fargli indossare una maglia asciutta e, non sapendo cosa fare, l’ho lasciato dopo avergli ingenuamente messo un ombrello aperto sul suo cuscino per riparargli il capo. Al buio nessuno parlava. Ogni tanto da Oreste proveniva un flebile lamento. Eravamo soli e quella notte non passava mai.
.
Lino e Titino Marsiglia
Venuto finalmente il giorno, mamma e zia Zaira lavano e disinfettano le ferite di Oreste e ci rendiamo così conto della loro gravità. Una grossa scheggia aveva trapassato e fratturato la sua spalla sinistra, molte altre gli avevano dilaniato le gambe ed una sola, di striscio, il viso. Nessuno sapeva cosa fare e dove andare, la disperazione ci attanagliava. Inaspettati, come due angeli custodi, entrano in casa i nostri giovani amici Lino e Titino Marsiglia, i quali, avendo saputo della nostra disgrazia, dopo aver sistemato la loro famiglia in una specie di rimessa, in campagna nel castagneto presso il cimitero di Terelle, sono venuti da noi per proporci di andare con loro. è stata la nostra salvezza. Avevano anche incontrato e condotto a casa nostra due militari della Croce Rossa tedesca che volevano portare via solo il ferito per ricoverarlo in un vicino ospedale da campo ma mamma, per paura di non potere più rintracciare il figlio, si oppone e i due miliari allora ci salutano e vanno via dopo aver dato ad Oreste un paio di compresse.
Prese le cose al momento più necessarie, seguiamo i due fratelli che portavano in braccio il piccolo ferito. Nell’andare ci si fa incontro una donna, anche lei disperata e che vagava sperduta senza meta perché aveva perso i contatti con la famiglia presso cui lavorava. Si chiamava Luisa ed era la fantesca della famiglia Golini Petrarcone di Cassino. Rinfrancata, si accoda a noi e da allora ha condiviso la nostra sorte.
A Cassino, prima dello sfollamento, la famiglia Marsiglia abitava vicino a noi nel rione Tre Colonne e Oreste soprattutto, studente di prima ginnasiale, ne frequentava la casa per fare i compiti. Il capo famiglia Francesco, amichevolmente chiamato don Ciccio, uomo gioviale e buono, era il dirigente dell’ufficio imposte di Cassino. La moglie, Maria Verile, maestra, era una donna pia e molto caritatevole. Avevano tre figli, Lina, Lino e Benedetto (chiamato affettuosamente Titino), tutti e tre particolarmente brillanti nello studio e nella vita sociale. Erano per noi più piccoli dei miti, soprattutto Lino, che eccelleva anche nello sport e come indimenticabile protagonista delle commedie che venivano rappresentate “dentro Corte”. Dopo l’8 settembre del 1943 Lino, che frequentava con profitto l’Accademia militare di Modena, era riuscito appena in tempo ad evitare di essere preso prigioniero dai tedeschi ed era tornato a casa a Cassino dopo molte peripezie.
Giunti nel ricovero, la signora Marsiglia e la sua anziana madre, Assunta Giuseppone, ci aiutano a sistemare le poche cose che avevamo portato e cercano amorevolmente di consolarci malgrado i problemi seri che anche esse avevano: Lina era ammalata gravemente di tifo e non avevano medicine per curarla adeguatamente. Solo quella sera Erberto, che fino ad allora non aveva detto nulla, comincia a lamentarsi e ci mostra la ferita abbastanza profonda e lunga dall’alluce al tallone che una scheggia di striscio, lacerando la scarpa, gli aveva procurato. Per la verità nessuno dette grande importanza alla cosa. Rimasti i soli abili della famiglia, mamma ed io facevamo la spola tra il rifugio e la casa di Terelle per prendere quello di cui avevamo bisogno e spesso eravamo sorpresi dai cannoneggiamenti sempre più frequenti, dai quali trovavamo riparo soltanto buttandoci a terra nella neve o accovacciandoci dietro i muri a secco.
L’inverno era particolarmente rigido e la neve abbondante serviva, una volta sciolta, per dissetarci, cucinare quando c’era qualcosa da mangiare, lavarci. Eravamo pieni di pidocchi e di tutte le razze! Mamma li trovava numerosi anche nelle ferite di Oreste che ogni mattina lavava e disinfettava versandoci dentro un cucchiaino di alcool denaturato, recuperato nella casa di Terelle. E pensare che solo pochi mesi prima, giocando alla guerra con i nostri compagni del vicinato, alle domande gridate dal comandante di turno: “L’Italia che fa? L’Inghilterra che fa?” rispondevamo con orgoglio: “L’Italia odora, l’Inghilterra fa schifo” e aggiungevamo, ridendo, “Re Giorgio tiene i pidocchi nella barba”. La nostra zona era continuamente battuta dalle artiglierie alleate perché poco più in alto, di sera e soprattutto di notte, transitavano carovane di muli che portavano i rifornimenti ai soldati in linea ed era quindi pericoloso uscire allo scoperto, specialmente di giorno con il sole, poiché gli osservatori alleati notavano immediatamente ogni piccolo movimento ed ordinavano alle batterie di sparare: i soldati tedeschi si muovevano liberamente solo quando indossavano le tute bianche. La necessità ci costringeva comunque a sfidare la sorte e perciò ogni giorno Lino, don Ciccio, Titino ed io, in fila indiana, passando per le zone più coperte e meno visibili agli osservatori alleati, andavamo, spesso senza successo, in paese a frugare nelle case abbandonate in cerca di cibo. Niente, solo del grano, che naturalmente veniva preso, e di tanto in tanto poche patate che, bollite, venivano consumate soprattutto dai malati e dai feriti. Per gli altri grano spaccato e bollito o grano appena tostato. Una volta, passando per il sentiero battuto dalle carovane dei rifornimenti, accanto alla carogna di uno dei tanti muli sventrati dalle cannonate, Lino scorse due pagnotte di pane tedesco, quello a cassetta. Che festa! Completato infruttuosamente il giro prestabilito, tornati a casa, il pane venne razionato. Ricordo ancora con che cura e con che precisione Lino tagliava le fette sottili come un’ostia e le distribuiva una al giorno a noi, raccolti in cerchio attorno a lui. Quel pane, desiderato come un dolce, bastò per tre giorni.
.
Una contadina
Eravamo andati, mamma ed io, a casa in paese per prendere cose necessarie e avevamo percorso, come al solito, un tratto abbastanza lungo allo scoperto, che i tedeschi evitavano o attraversavano di corsa perché battuto frequentemente dall’artiglieria. L’andata era stata tranquilla: gli osservatori alleati non potevano scorgerci poiché la zona era avvolta da una leggera nebbiolina che, purtroppo, era svanita non appena giunti in paese. Mentre mamma raccoglieva le sue cose nella camera al primo piano, io prendevo l’occorrente da una parte all’altra della stanza a pianterreno, scavalcando per la fretta il corpo di papà.
Ripresa la via del ritorno, un violento cannoneggiamento ci sorprende al limitare del paese, all’inizio della zona scoperta. Mamma trova rifugio in una piccola cappella votiva e io, che la precedevo di una ventina di metri, disteso a terra vedevo intorno a me gli schizzi di neve sollevati dalle schegge e aspettavo di essere colpito da un momento all’altro. Ritornata finalmente la calma, mi accorgo che la cappelletta in cui si era riparata mamma non esisteva più. Era stata completamente rasa al suolo. Disperato, mi accingevo a frugare tra le macerie, quando la vedo uscire da sotto una tettoia che era di fronte alla cappella dall’altra parte della mulattiera. Incredulo, la toccavo e lei, pallida, mi accarezzava mentre, ripreso il cammino, mi diceva: “Questa mattina la Madonna non ha voluto farvi rimanere ancora più soli. Mentre le granate ci scoppiavano vicine, una contadina, senza parlare, con la mano mi aveva più volte fatto cenno di andare da lei sotto quella tettoia e io l’ho raggiunta proprio nel momento in cui la cappella veniva colpita. Non abbiamo parlato e quando tutto era finito non l’ho più vista. “Passata la guerra tutte le volte che ricordavamo quell’episodio mi diceva, anzi si chiedeva “Può essere che quella donna vestita da contadina fosse proprio la Madonna?”. Io la prendevo in giro e lei rimaneva a guardarmi, dubbiosa.
.
Il vecchio
Una mattina, nevicava fitto, si presentò alla porta della nostra stamberga un vecchio dal viso scavato, con la barba incolta, gli occhi arrossati forse dalla febbre, i vestiti a brandelli, stretto in una mantella grigioverde alquanto lacera. Si appoggiava ad un bastone ed aveva in mano a mo’di gavetta un barattolo di latta con il manico di fil di ferro. Con molta umiltà, levandosi il cappello pieno di neve, chiese di poter entrare e di rimanere con noi. Naturalmente fu accettato e si provvide a dargli un materasso e una coperta. Non abbiamo mai saputo chi fosse e da dove provenisse. Si alzava di tanto in tanto per uscire a fare i suoi bisogni e non chiedeva mai nulla, accettava con un sorriso il cibo che io o Erberto gli mettevamo nel suo barattolo e ci benediceva. Rimase con noi una quindicina di giorni. Una mattina non si svegliò, era morto senza un lamento. Il corpo del povero vecchio fu adagiato su una scala che Lino aveva procurato chissà dove e Lino stesso, don Ciccio, Titino, seguiti da me che non li lasciavo mai, lo portarono nel cimitero già mezzo diroccato di Terelle.
.
Liliana
I cannoneggiamenti si susseguivano sempre più intensi e i bombardamenti sulle a noi vicine linee tedesche sempre più frequenti. Solo chi lo ha provato può capire come e perché il solo rombo dei motori delle squadriglie di fortezze volanti gelasse il sangue e paralizzasse i movimenti. Le batterie tedesche intorno a noi rispondevano al fuoco nemico con altrettanta intensità: eravamo tra due fuochi.
Un giorno, approfittando della nebbia che avvolgeva la zona, ci siamo trasferiti in un’ abitazione all’apparenza più sicura e più comoda. Non ci seguirono il sig. Giallonardi (anziano e buono, ma malato e brontolone) e la moglie Marzocchella, (non ne ricordo purtroppo i nomi), che da qualche tempo si erano uniti a noi e che saranno poi fucilati la notte del rastrellamento perché la donna non volle abbandonare il marito incapace di camminare. Ci siamo istallati al piano terra, pensando che l’unica camera del piano superiore potesse ripararci meglio dai proiettili di artiglieria. Intanto, sempre e con grande rischio, continuavamo a raccogliere la neve e ad entrare in cerca di cibarie nelle case abbandonate e diroccate dove spesso trovavamo cadaveri, soprattutto di vecchi. Anche mamma con in braccio il piccolo Edoardo di due anni, che non voleva mai lasciarla, instancabile, si dava da fare e si avventurava allo scoperto per andare nella nostra casa di Terelle per prendere cose necessarie e, il più delle volte, ritornava sconvolta perché sorpresa dal fuoco alleato.
Una mattina eravamo, come al solito, di “ispezione” quando, passando vicino ad un piccolo casolare mezzo diroccato, un pianto disperato ha attirato la nostra attenzione. Entrati, una scena agghiacciante si è presentata ai nostri occhi: su un lettino, coperte soltanto da un lenzuolo, due donne con indosso una leggera camicia da notte, giacevano abbracciate. La più anziana, morta certamente assiderata, ancora stringeva a sé la più giovane che, atterrita e ormai quasi senza più forze, tentava inutilmente di liberarsi. Erano mamma e figlia a cui alcuni soldati avevano portato via qualche giorno prima coperte, indumenti e le scarpe. Per le loro necessità avevano dovuto camminare scalze nella neve, e, senza cibo, in quella stanza dalla finestra senza vetri si erano tenute strette per tentare di riscaldarsi a vicenda. Tutte e due avevano i piedi congelati. Immediatamente liberata e rassicurata, Lino la prese in braccio e la portò da noi dove fu accolta, rivestita, consolata, rifocillata e curata come una figlia dalla signora Marsiglia che ogni giorno con le bende che rimediava strappando le lenzuola le fasciava i piedi dopo averli lavati con acqua calda.
La Giovanetta si chiamava Liliana e non aveva più di quindici o sedici anni. Un destino crudele la legherà per sempre alla “nuova mamma” che così amorevolmente la curava. Quella sera e per buona parte della notte un violento cannoneggiamento rase al suolo, tra l’altro, il casolare di Liliana e il corpo della madre sventurata rimase così sepolto sotto le macerie. La ragazza era stata salvata appena in tempo.
.
Il rastrellamento
Eravamo ormai giunti ai primi del mese di marzo. Oreste era sempre più in preda alla febbre alta e, specialmente di notte, delirava per ore aumentando a dismisura l’angoscia di tutti. Intanto a poche centinaia di metri da noi la battaglia infuriava, il crepitio delle armi automatiche si faceva sempre più vicino e ci dava la speranza di un imminente arrivo degli alleati. Speranza vana. I tedeschi riuscivano sempre a respingere lontano gli assalitori e, a sera tardi, talvolta qualche pattuglia di rientro dal fronte circondava la nostra casa e due o tre soldati entravano con le armi spianate e con una lampada tascabile scrutavano uno ad uno noi, che coricati, morivamo di paura. Sentendoli arrivare Lino e Titino, per timore di essere presi e deportati, si nascondevano tra il muro e i materassi, coperti dalle lenzuola e dai cuscini.
Il cielo ormai quasi sempre sereno permetteva agli aerei e ai cannoni alleati di non dare tregua e una “bella” mattina la nostra casa fu centrata da una granata. Schizzati all’aperto per rientrare subito perché le esplosioni si susseguivano intorno a noi, constatammo con sollievo che nessuno di noi era stato ferito sebbene le numerose schegge che avevano perforato il soffitto avessero squarciato alcuni materassi, bucato quasi tutte le pentole e riempito di calcinacci tutta la stanza.
La neve ormai cominciava a sciogliersi e quella nelle vicinanze della casa era mista alla terra sollevata dalle cannonate e dalle bombe. Bisognava andare sempre più lontano e nelle zone esposte a Nord per raccoglierne di pulita. Quel pomeriggio del 21 marzo ci eravamo allontanati più del solito e con i secchi colmi di neve pulita stavamo rientrando chiacchierando tra noi, senza dare importanza a delle voci che sentivamo lontane. Improvvisamente ad una certa distanza dalla casa alcuni soldati tedeschi, con i mitra spianati, ci intimarono di alzare le mani e di proseguire per riunirci a tutti gli altri che, addossati al muro e sotto la minaccia delle armi, ci aspettavano terrorizzati mentre all’interno altri soldati frugavano in cerca di una radiotrasmittente o di qualcuno. Eravamo convinti di essere fucilati. A Lino e Titino che parlavano il tedesco per averlo studiato e che chiedevano che cosa mai cercassero, un graduato rispose solo di avere avuto l’ordine di portarci via.
Cominciava così un altro doloroso e più tragico trasferimento poiché Oreste e Liliana, che giacevano sulla neve, non erano in grado di camminare, gli altri anziani o malati potevano farlo con molta difficoltà. I militari erano visibilmente stanchi e irritati e, con ordini secchi, ci fecero mettere in marcia. Uno di loro prese Oreste a cavalcioni, altri due afferrarono per le ascelle la povera Liliana che, non riuscendo con i piedi congelati a tenere il loro passo, veniva trascinata, per cui, dopo qualche centinaio di metri, la sventurata aveva perduto tutte le dita dei piedi; mamma con Edoardo in braccio procedeva a fatica, come pure zia Zaira, nonna Assunta, la signora Marsiglia, la giovane Lina e Luisa. Avevamo preso in salita il sentiero percorso dai muli con i rifornimenti per il fronte e spesso affondavamo fino alle ginocchia nella neve alta e molliccia, per cui subito io ed altri perdemmo le scarpe. Malgrado la ferita al piede, Erberto procedeva senza lamentarsi. Giunti a notte ormai fonda su un pianoro, fu dato l’ordine di fermarci e di aspettare e, mentre i tedeschi si rifocillavano in alcune casematte poco distanti, noi, seduti sulla neve, uno accanto all’altro in cerca di tepore, stemmo in un dormiveglia colmo di ansia e di paura. Tornati, i soldati volevano lasciare gli inabili sul posto, dicendo che sarebbero stati recuperati all’alba dai mulattieri di ritorno dal fronte. Si scatenò una lotta violenta. Mamma saltava da un militare all’altro e lo trascinava vicino ad Oreste, gridando e supplicando di non abbandonarlo. I soldati si svincolavano, la respingevano con modi rudi e violenti, ma lei non si arrendeva. Riuscì finalmente a convincerne uno che, preso in spalla il piccolo ferito, raggiunse gli altri già in cammino. Stranamente, senza essere sollecitati, un altro soldato aveva preso su di sé l’anziana zia Zaira che poi, di tanto in tanto, lungo il percorso veniva scaraventata come un sacco sulla neve e un altro ancora aveva raccolto il piccolo Edoardo che dormiva avvolto in una coperta. Purtroppo per la signora Marsiglia, per la nonna Assunta e per Liliana non ci fu nulla da fare. Lino e Titino più volte anche essi avevano tentato di soccorrerle e di impedire che venissero abbandonate, ma i pugni, i violenti colpi con i calci dei fucili, lo scatto delle armi caricate e spianate avevano costretto i due fratelli a desistere per non essere uccisi e anche per non lasciare soli la sorella Lina e il padre, in grande difficoltà nella neve alta. Lino, però, non si dava pace e ad ogni occasione tentava di tornare in dietro ma sempre i militari che chiudevano la marcia gli imponevano di andare avanti minacciandolo con le armi puntate. Procedevamo in fila indiana, il sentiero era stretto e spesso dovevamo arrampicarci sulla costa alla nostra sinistra per lasciare il passo alle carovane dei rifornimenti che, veloci, andavano verso il fronte. In un tratto particolarmente impervio uno dei muli di passaggio, scartando, fece cadere don Ciccio in un burrone alquanto profondo costringendo Lino a rischiare un pericoloso recupero per riportare tra noi il padre sempre più stanco e avvilito e ancora più in difficoltà per aver perduto gli occhiali.
All’alba una dopo l’altra le carovane dei rifornimenti cominciarono a tornare e a superarci, ma nessuna di esse aveva raccolto le donne abbandonate: i muli portavano legati ai loro basti i cadaveri di alcuni soldati tedeschi caduti forse il giorno precedente. Giunti finalmente a Colle San Magno, un paese alle spalle di Terelle sull’altro versante di monte Cairo, i nostri “accompagnatori” ci riunirono in una sala di un palazzo dove un grande fuoco ardeva in un ampio camino. La zia Zaira era stata distesa su una panca vicino al focolare, era sfinita e noi tutti dovevamo essere in uno stato talmente pietoso da indurre un ufficiale tedesco ad ordinare di portarci del cibo per rinfrancarci. Ci portarono del riso ben caldo ma, per la stanchezza, per il dispiacere per la perdita di persone care, per l’angoscia che ci attanagliava, per il dolore insopportabile dei piedi nudi e gonfi, non ne mangiammo che poche cucchiaiate. Dopo qualche tempo avemmo l’ordine di muoverci per essere trasferiti altrove e allora Erberto ed io, visto che zia Zaira non si muoveva, credendola ancora addormentata per la stanchezza, cominciammo a scuoterla e a chiamarla per farla svegliare. Solo l’ufficiale tedesco aveva notato che era morta e ce lo disse in italiano con una certa delicatezza, aggiungendo, come per consolare il pianto di noi due piccoli, che l’avrebbe fatta seppellire da un nostro connazionale.
Un camion militare ci portò a Frosinone ormai deserta dove passammo la notte rinchiusi in una stanza di una casa in cui alcune “signore”, forse le sole rimaste in paese, intrattenevano i soldati tedeschi in licenza. La mattina dopo un mezzo della Croce Rossa italiana ci scaricò a Fiuggi. Alcuni infermieri ci spidocchiarono con della polvere insetticida, ci fornirono qualche indumento, delle scarpe larghe e lunghe, comode comunque per i miei piedi ancora gonfi e doloranti e ci ricoverarono nella Casa del Maestro, piena di soldati tedeschi in convalescenza. Fummo in qualche modo curati ed assistiti e, anche se Oreste non poté essere operato per la mancanza di attrezzature, un poco di conforto lo avemmo tutti, anche se la fame ci tormentava più che mai.
La vita a Fiuggi era quasi normale, non si sentivano più gli scoppi delle granate e si poteva uscire per strada e incontrare e parlare con la gente senza pericolo. Avevamo bisogno di tutto e nessuno, neanche alcuni conoscenti di Cassino sfollati a Fiuggi da tempo, ci aiutava. L’unico sostegno lo avemmo da un parente di mia madre, zio Attilio Vallerotonda, il quale, saputo del nostro arrivo, veniva a trovarci quasi ogni giorno e generosamente portava sempre qualche cosa da mangiare a noi che lo aspettavamo speranzosi affacciati alla finestra.
Verso la metà di aprile trovammo posto su un camion della Croce Rossa. Un altro distacco doloroso ancora ci aspettava: la marcia in montagna a piedi nudi nella neve era stata fatale a Luisa che, ammalata di tetano e senza cure, con la mascella bloccata dal male ululava il suo dolore e la sua disperazione in una cameretta in isolamento. Noi ci fermammo a Roma, i Marsiglia proseguirono per Ascoli Piceno.
Rintracciati a fatica i nostri parenti, ci dovemmo dividere tra le varie case e Oreste finalmente poté essere ricoverato al Policlinico e affidato alle cure del prof. Girolamo Matronola, cassinate e collega di mio padre, che lo sottopose a diverse operazioni, avendogli riscontrato una grave forma di osteomielite e di anemia per l’insufficiente alimentazione e per il molto sangue versato. Finalmente noi altri potemmo riunirci in un appartamentino in via Nomentana, concessoci dalla famiglia Abruzzini grazie all’interessamento di un nostro zio, ed eravamo più sereni benché la nostra vita si svolgesse nelle ristrettezze più assolute perché eravamo privi della tessera annonaria e perché nella borsa, che, avvolta con stracci per evitare la cupidigia di qualche tedesco, mia madre mi aveva affidato la sera del rastrellamento con la raccomandazione di non lasciarla mai e di non perderla, vi erano dei buoni del tesoro ormai senza più valore, il contratto di assicurazione sulla vita di mio padre, non riconosciuto più valido dalla compagnia assicuratrice perché non erano state pagate le ultime rate e un orologio da tasca d’oro, dalla cui vendita fu ricavato il necessario per vivere per alcuni giorni: al mercato nero anche i prezzi dei beni di prima necessità erano molto alti. Tutti gli altri nostri averi, che, contro il parere di mamma, erano stati fatti murare “in un luogo sicuro da persone fidate” non saranno più ritrovati. Grande era comunque il rimpianto e lo sconforto che prendeva noi nel constatare la normalità della vita romana: i negozi aperti, la gente passeggiare, fare la spesa, andare a messa e addirittura al cinema e perciò mamma talvolta la sera piangeva nel letto non trovando una risposta convincente ai perché della scelta che ci aveva portato nell’inferno di Terelle.
.
La ricerca dei caduti
Dopo la liberazione di Roma, tornati a Cassino completamente distrutta, ci siamo sistemati alla meglio nell’unica stanza, appena agibile dopo essere stata sommariamente riparata, di un casolare della nostra campagna che era piena di proiettili, di armi abbandonate, di carri armati, di cannoni fuori uso e di alcune croci. Malgrado le gravi difficoltà da affrontare e i complessi problemi da risolvere per iniziare la bonifica e la ricostruzione, mamma aveva sempre fisso il pensiero di andare a ritrovare i nostri morti. Appena le fu possibile partì per Terelle accompagnata da un paio di nostri contadini da poco tornati dallo sfollamento e in una fossa comune, dalla mantella militare che ancora li avvolgeva, riconobbe ed estrasse per quanto possibile (le gambe dal ginocchio in giù ,coperte da altri corpi, rimasero nella fossa) i resti del marito, che, composti in una cassa fatta fare alla meglio da un artigiano del luogo, portò su un carro agricolo nel cimitero di Cassino. In quella stessa fossa non le fu possibile riconoscere le ossa del vecchio zio Edoardo. Qualche tempo dopo mamma si recò a Colle San Magno dove, indagando, chiedendo, su indicazione di colui che l’aveva sepolta, riuscita a trovare la tomba di zia Zaira, ne raccolse le ossa in una cassetta e le portò al cimitero di Cassino viaggiando in autobus.
Anche la famiglia Marsiglia avvertiva lo stesso bisogno e perciò Titino, appena ritornato, rifece il percorso da noi fatto quella notte terribile e scorse su quel pianoro una croce vicino a una roccia sulla quale era scritto: “Due ragazze italiane sconosciute”. Il giovane figlio, piangendo, raccolse le ossa della madre e quelle di Liliana in una sola cassetta e ora le due riposano per sempre insieme nel cimitero della nostra città. Anche Titino non riuscì a trovare i resti della nonna Assunta.
.
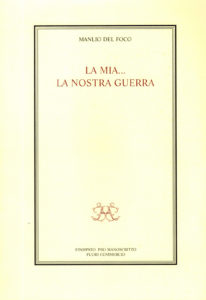 Questo ricordo, per me doloroso, che spesso tormenta il mio sonno, scritto in forma stringata e arida, è dedicato alle persone care che ho perduto, a mia madre, eroica e a tutta la famiglia Marsiglia, soprattutto a Titino e a Lino a cui certamente dobbiamo la vita.
Questo ricordo, per me doloroso, che spesso tormenta il mio sonno, scritto in forma stringata e arida, è dedicato alle persone care che ho perduto, a mia madre, eroica e a tutta la famiglia Marsiglia, soprattutto a Titino e a Lino a cui certamente dobbiamo la vita.
.
Manlio Del Foco, La mia … la nostra guerra, pro manuscripto fuori commercio, Tipogr. F. Ciolfi, Cassino 2013, pp. 56, illustr. col. e b./n.; f.to cm. 17×24
.
(166 Visualizzazioni)



